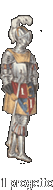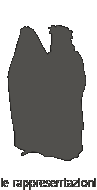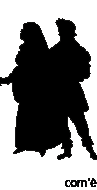Il San Carlo, nell'ambito del rinnovamento urbanistico della città, prende il posto del piccolo Teatro San Bartolomeo. Il progetto è affidato all'architetto Giovanni Antonio Medrano, Colonnello del Reale Esercito, e ad Angelo Carasale, già direttore del San Bartolomeo.
Il disegno di Medrano prevedeva una sala lunga 28,6 metri e larga 22,5 metri, con 184 palchi, compresi quelli di proscenio, disposti in sei ordini, più un palco reale capace di ospitare dieci persone, per un totale di 1379 posti.
Otto mesi dopo l'inizio dei lavori, il 4 novembre, il teatro è già ultimato. Fu inaugurato nel 1737
L’interno della struttura è, oggi, ricostruibile sulla base di un dipinto di
Michele Foschini e di alcuni rilievi eseguiti da architetti europei in visita alla sala, come lo svedese
Carl Fredrik Adelcrantz, autore dei teatri delle residenze reali di Ulriksdal e Drottningholm e il francese
Gabriel-Pierre-Martin Dumont.
Quest’ultimo, giunto a Napoli nel 1751 al seguito di Abel Poisson, fratello di Madame de Pompadour e futuro marchese di Marigny, contribuisce alla notorietà internazionale della fabbrica pubblicando il volume di disegni «Parallèle des plans des plus belles salles de spectacle d'Italie et de France...» e le incisioni edite nel decimo volume dell'Encyclopédie di
Diderot e D'Alembert (1772).
Le numerose testimonianze tramandate da viaggiatori e visitatori sono concordi nel celebrare la vastità della sala e dei palchi, pur se a discapito dell'acustica e della sontuosità delle decorazioni. Non di rado si riscontrano singolari osservazioni, come quella del chirurgo inglese Samuel Sharp che nel 1765 nota le originali poltroncine della platea dotate di schienali pieghevoli e chiudibili con serrature.
Durante il Settecento, l'edificio vede diversi ammodernamenti sollecitati dalle mutate esigenze del gusto o dalla necessità di migliorarne l'acustica, come l'intervento del 1742 diretto da Giovanni Maria Galli Bibiena il Giovane.
Ristrutturazioni permanenti sono eseguite da Ferdinando Fuga (1699-1782), prima nel 1767-68 in occasione del matrimonio di Ferdinando IV con Maria Carolina e poi nel 1777-78.
Con i primi lavori l'architetto toscano rinnova la decorazione dell'auditorio e inserisce nei palchi grandi specchi provvisti di torciere con candele che, sfruttando l'effetto di riflessione, moltiplicano l'illuminazione della sala producendo, secondo il compositore inglese Charles Burney, «uno splendore troppo abbagliante per gli occhi».
Il successivo intervento riguarda quasi esclusivamente il boccascena, ricostruito con il raddoppio dei pilastri e l'inserimento dei palchi di proscenio.
Nel 1797 la sala viene sottoposta ad un nuovo restauro decorativo sotto la direzione dello scenografo del teatro
Domenico Chelli (1746-1820). Questo intervento è però poco apprezzato dalla critica settecentesca soprattutto per la soluzione adottata nel soffitto con un finto pubblico dipinto sul velario.
La breve parentesi della Repubblica Partenopea del 1799 non porta particolari modifiche alla struttura, ad eccezione di alcuni danni provocati dall'uso improprio della sala, ribattezzata Teatro Nazionale e «profanata» da spettacoli equestri.
Domenico Barbaja è particolarmente interessato ad avviare una ristrutturazione del Teatro volta all’inserimento di nuovi ambienti adibiti alla sua attività di appaltatore di giochi d'azzardo.
Regista delle trasformazioni è Antonio Niccolini (1772-1850). Il caposcuola del Neoclassicismo a Napoli interviene a più riprese sull'edificio che progressivamente acquisisce la fisionomia odierna.
La prima fase della metamorfosi riguarda la facciata, con la conseguente aggiunta del ridotto e degli ambienti di ricreazione e ristoro.
I lavori, avviati già nel dicembre 1809, si concludono due anni dopo.
Il portico carrozzabile sostenuto da pilastri si ispira al modello offerto dalla Scala (1776-78) di Giuseppe Piermarini, modificato tuttavia dall'inserimento, al secondo registro della facciata, della loggia ionica corrispondente agli ambienti del ridotto.
Con Niccolini il Teatro acquisisce, così, le connotazioni del tempio diventando monumento-simbolo della città. La facciata, infatti, ingloba elementi della grammatica classicista e una decorazione ellenizzante allusiva alla poesia drammatica e alla musica.
Altrettanto interessante è il ridotto: una grande sala tetrastila, con una decorazione vegetale in oro, fiancheggiata da ambienti minori destinati alle sale da gioco. Attraverso la loggia ionica si affaccia sulla via di San Carlo ed è oggi sede del Circolo dell'Unione.
Un anno dopo la conclusione dei lavori dell'avancorpo, l'architetto toscano adegua la sala alla nuova decorazione del vestibolo e delle scale. Tra le innovazioni eseguite, si ricordano le coppie di semicolonne addossate ai pilastri già realizzati da Fuga nel proscenio, il lampadario sospeso nella zona più oscura della sala e il rifacimento del velario sostenuto da aste con cariatidi. Al centro di questo è raffigurata l'apoteosi degli uomini illustri con Minerva circondata dalla Muse e da Apollo, soggetto conservato anche nelle successive edizioni della sala.
La ricostruzione, compiuta nell’arco di nove mesi, è sempre diretta Antonio Niccolini che ripropone a grandi linee la sala del 1812. L’architetto toscano ne conserva, infatti, l'impianto a ferro di cavallo e la configurazione del boccascena, sebbene allargato e ornato nella superficie interna dal bassorilievo raffigurante il Tempo e le Ore, ancor oggi esistente.
Il disegno dei rilievi delle balaustre si ispira alle tavole contenute nel primo tomo delle
Antichità di Ercolano (1757), alternate a fregi in oro e argento.
Nella copertura Niccolini semplifica il dispositivo messo in opera nel 1812, utilizzando aste raccordate ad un velario «all'antica», soluzione già adottata dall'architetto dieci anni prima nel Teatro degli Avvalorati a Livorno (1806).
Quale «Architetto decoratore de' Reali Teatri», Niccolini dirige anche i successivi interventi di manutenzione e di restauro. Fra questi si ricorda l'ammodernamento compiuto nel 1844, insieme al figlio Fausto e a Francesco Maria dei Giudice, di cui rimane testimonianza in una memoria autografa pubblicata nello stesso anno.
I lavori riguardano la trasformazione della tappezzeria dei palchi da azzurro in rosso e il rifacimento delle decorazioni per adeguarle alla nuova tonalità dominante nella sala.
A tal fine anche il tondo centrale del velario viene ridipinto da
Antonio, Giuseppe e Giovanni Cammarano riprendendo il soggetto delle precedenti edizioni. Il sipario completa l'arredo fisso della sala: più volte ridipinto da Giuseppe Cammarano, è sostituito nel 1854 dall'attuale esemplare dovuto a
Giuseppe Mancinelli e Salvatore Fergola, raffigurante un «simbolico Parnaso» con ottanta poeti e musicisti.
Ma la fabbrica del Teatro non può dirsi completa senza menzionare la facciata laterale realizzata su progetto di
Francesco Gavaudan e Pietro Gesuè a seguito dell'abbattimento dell'ultimo baluardo del Palazzo Vecchio (1838-42).
Nel 1860 con l'unità d'Italia comincia un lungo periodo di decadenza e abbandono del teatro.
Il 27 marzo 1969 il gruppo scultoreo niccoliniano della Partenope, presente sul frontone della facciata principale, si sgretola per le infiltrazioni causate dalla pioggia e viene rimosso.
L'attuale foyer, realizzato nella zona orientale del giardino di Palazzo Reale è, invece, realizzato nel 1937 su disegno di Michele Platania. Distrutto da un bombardamento nel 1943 è stato ricostruito nell'immediato dopoguerra.
L'11 giugno 2007, la Triade della Partenope ricostruita, finalmente è tornata ad erigersi sulla sommità dell'edificio.
Il 23 gennaio 2009 il Teatro di San Carlo è stato restituito alla città. È stato costruito un nuovo Foyer al di sotto della sala teatrale; la sala stessa è stata restaurata, con la completa pulizia di tutti i rilievi decorativi, gli ori, le cartepeste e le patine meccate ed è stato inoltre aggiunto un impianto di climatizzazione, per il quale il flusso dell'aria è immesso nella platea attraverso una bocca posizionata al di sotto di ognuna delle 580 poltrone, ed in ogni singolo palco della sala. Il restauro della tela di 500 metri quadrati, posta a decorare il soffitto della sala, ha richiesto l'impiego di circa 1500 chiodi e 5000 siringate per il fissaggio della pellicola pittorica. Inoltre sono state interamente sostituite le poltrone della platea, la quale ha subito anche un intervento per il miglioramento della visuale degli spettatori e dell'acustica, già giudicata straordinaria prima dell'intervento.
Il teatro sarà nuovamente chiuso al pubblico a partire da giugno 2009 per un nuovo intervento, che prevederà il rifacimento del palcoscenico, e ancora nel 2010 per un intervento sulla facciata e per gli ultimi ritocchi.