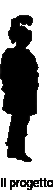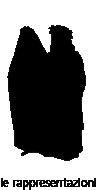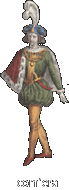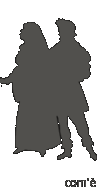INQUADRAMENTO STORICO. TECNICHE DI ESECUZIONE
L’attuale aspetto strutturale della Cavea è frutto della ricostruzione totale del Teatro a seguito di un devastante incendio avvenuto il 13 Febbraio del 1816, da cui scamparono solo le strutture in muratura.
Il disastro fu l’occasione per un radicale e definitivo intervento di rinnovamento, portato a termine dal 1816 al 1817.
La struttura portante delle 6 fasce balaustrate, sottolineate dal ritmo elegante della decorazione, è realizzata in legno di tiglio.
In ogni ordine di palchi ritroviamo articolati i tipici temi decorativi dell’epoca.
Dopo ogni tre palchi ne segue uno la cui balaustra porta bassorilievi – originariamente in argento – in cui ricorrono motivi con fregi, amorini, sirene,strumenti musicali ed
“altri convenienti ornamenti”.
Un gran numero di motivi ornamentali, che arricchiscono le strutture di base, furono eseguiti in cartapesta, si pensa, per una scelta di acustica.
Le cronache dell’epoca (Stendhal) ci dicono che il 12 Febbraio 1817, quando il nuovo Teatro fu inaugurato, le finiture delle decorazioni si presentavano
in argento brunito (lucidato con pietra d’agata), con riporti in oro zecchino brunito e a missione, in un gioco di contrappunto con l’azzurro cupo scelto per le balaustre e la tappezzeria dei palchi.
Nel 1854, con un nuovo intervento di restauro, si scelse di rinnovare completamente la finitura delle decorazioni. La tempera dei fondi diventava color avorio-giallino, le tappezzerie, rosse.
I riporti precedenti in oro zecchino brunito e a missione furono lasciati inalterati
(ad es. panneggi, oggetti, strumenti musicali ecc… nelle scene degli amorini).
Tutto il resto, utilizzato come base l’argento del 1816, fu ricoperto in parte con oro zecchino in foglia,applicato a missione - ed in parte velato a Mecca (vernice simil-oro).
Questo è l’aspetto con cui la Cavea si è conservata sino ai nostri giorni.
STATO DI CONSERVAZIONE- PROBLEMI DI RESTAURO
L’intera superficie del teatro si presentava offuscata da un considerevole deposito di polvere, che raggiungeva, in alcuni casi, anche i 5 mm, e di materiale particellare di vario genere, difficilmente rimuovibile semplicemente spolverando. Le cause più probabili di questi ultimi depositi sono da ricercare nei fumi delle candele e delle torce da illuminazione (abbondantemente utilizzate prima dell’elettrificazione delle lampade), nell’uso di vari sistemi di riscaldamento, e non ultimo nella presenza tra gli spettatori di una vasta categoria di fumatori.
---------------------------
Nella sua totalità, lo stato di conservazione non presentava problematiche particolarmente gravi.
Erano presenti sistematiche e profonde fenditure tra le assi lignee nei punti di giunzione dell’impianto delle balaustre e dei palchetti, e imbarcamenti di alcuni pannelli di supporto alle scene con gli Amorini, con conseguenti ampie fessurazioni tra i pannelli e le cornici in legno meccato, delle scene medesime.
- Tutto ciò, naturalmente, poiché il legno, date le sue proprietà, tende a subire variazioni di dimensioni in presenza di umidità e di sbalzi di temperatura, creando così lesioni,che propagandosi in senso parallelo all’andamento delle fibre, possono interessare parzialmente o totalmente un supporto.-
---------------------------
Sulle decorazioni ad oro e mecca, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti nel corso degli ultimi secoli,erano estremamente diffusi e non organici. Numerosissimi gli interventi di ritocco o “rinfresco” eseguiti nel corso del tempo, sia per dare alle parti in doratura e meccatura un senso di maggior brillantezza, sia per camuffare le tante mancanze, svelature e de coesioni della preparazione a gesso con conseguente perdita della decorazione.
I materiali più in uso, per questo tipo di intervento, erano vernici resinose di origine naturale (Mastice, Damar, Sandracca ecc.) facilmente alterabili. Infatti secondo la composizione e le condizioni di luce dell’ambiente, molte resine naturali si scuriscono nel tempo con sfumature cromatiche spesso molto varie. Alla coloritura o scurimento (si dice che ingialliscono) delle resine si associa poi quello degli oli e delle essenze impiegate nella composizione del prodotto verniciante(lino, noce, canapa ecc.). Anche le essenze (trementina, spigo, rosmarino), che venivano usati come diluenti delle vernici, ingialliscono e scuriscono, se esposti alla luce.
Inoltre, dove si era reso necessario camuffare, cadute di colore o usura delle finiture, era stata utilizzata una miscela a base di Vernice con aggiunta di Bitume o Asfalto,(in uso dal XIX sec.) e Polvere di metallo dorata (Porporina).
Di quest’ultima né è stata rilevata presenza massiccia in particolare per i ritocchi dei riquadri degli Amorini. La cromia delle polveri metalliche, unita al resto, si altera pesantemente rendendo i ritocchi facilmente individuabili ed estremamente disturbanti per l’armonia dell’insieme.
---------------------------
Le campiture pittoriche decorate a tempera avorio, oltre ad avere un aspetto leggermente ingrigito a causa dei depositi di polvere e particellare, erano interessate da una evidente alterazione ed ingiallimento della cromia originale e da estese cadute di colore che interessavano molta parte delle balaustre. Questo tipo di problema può avere varie origini: infiltrazioni d’acqua, anche se in min. quantità. Movimenti della struttura lignea di supporto incoerente con lo strato pittorico. Sovrapposizione di diversi strati di pittura, senza adeguato trattamento preparatorio sottostante, che provoca nel tempo lo sfaldamento della pittura in macro o micro cadute. Durante le indagini preliminari sono state effettuate(a bisturi) varie stratigrafie della decorazione da cui risulta, in effetti, la presenza di almeno 3 strati sovrapposti di pittura a tempera di diversa cromia. Partendo da un azzurro (in particolare nei fondi delle scene con Amorini), poi giallino- verdognolo e giallo pallido, per arrivare all’avorio attuale. Il tutto su una preparazione originale costituita da una tela grezza (a trama larga), incollata sulla struttura lignea e poi preparata con una “camicia di gesso”.
La combinazione di elementi, fin qui descritti, ad una prima osservazione, rimandava una sensazione di totale appiattimento ed ottusità cromatica dei decori.
Le problematiche di degrado più importanti erano circoscritte a zone specifiche:
- Ghirlande: collocate sul frontale delle colonne, accanto ai punti luce, attualmente costituiti da candelabri in metallo a più braccia, elettrificati.
Erano evidenti,una consunzione diffusa delle dorature e, soprattutto nelle parti alte a diretto contatto con la base delle lampade, le bruciature causate da cera calda e olio dell’antico sistema di illuminazione, che prevedeva inizialmente candele per arrivare poi ai lumi a petrolio.
- Palmette dei Capitelli (colonne Palchi): numerosissime le parti mancanti o spezzate. Fatta eccezione per due o tre casi (1° e 2° balaustra), in cui il danno era esterno, i modellati da ricostruire riguardavano essenzialmente le parti dei capitelli interne ai palchetti.
- Colonne fusto, parte interne dei palchi: usura molto accentuata, dalla 1° alla 5° balconata, delle parti basse della colonna, partendo dal poggiamano a salire di ca. 30 cm. (probabilmente dovuta all’ancoraggio metallico di un supporto per lampade utilizzato in passato, deduzione comprovata da segni evidenti di incisione profonda sui tre lati del fusto della colonna che ricorre in tutti i palchetti). I danni maggiori erano decoesioni dello strato preparatorio in gesso e doratura, usura della superficie, buchi (chiodi e perni), incisioni ed estesi ritocchi a Porporina.
L’interno delle colonne della 5° balaustra, diversamente dalle altre, rifinita a mecca, presentava nelle scanalature una forte alterazione della vernice simil-oro, diffusa su l’intera superficie. Oltre ad un’intensa Ossidazione dell’Argento di base.
- Riquadri con Amorini: i problemi più evidenti riguardavano soprattutto alcune scene localizzate – le prime in linea verticale di ogni balaustra, partendo dal proscenio
(4 per lato).
Qui il degrado è stato provocato essenzialmente da infiltrazioni d’acqua
(ci sono condutture nei pressi dei palchi) e, data l’estrema visibilità e importanza della posizione rispetto al palcoscenico, dai massicci interventi di “restauro e abbellimento”.
Appunto a causa di puliture, particolarmente Invasive praticate a più riprese nel tempo,soprattutto su alcuni rilievi, la finitura di oro a missione, con cui nel 1854 erano stati rinnovati i decori della cavea, si è usurata completamente sino a lasciare scoperte le originarie finiture in Argento brunito del 1816, peraltro, ottimamente conservate, nonostante una leggera ossidazione del metallo.
Pennellate casuali, non coerenti ed eccessivamente cariche di vernice molto scura
(bitume con porporina ed oli siccativi),che dato l’eccesso ha anche provocato numerose colature sui fondi a tempera. Ammaccature e sfaldamenti della cartapesta del modellato, provocati sicuramente da colpi inferti, fanno pensare ad interventi effettuati affacciandosi dai palchi con lunghe aste a cui erano fissati dei pennelli o altre attrezzature, in modo poco consono, frettoloso e poco agevole.
Lo stesso tipo di intervento si è riscontrato, anche se in misura minore, su tutte le scene della 2° balconata, ambite, perché vicine alla platea, ma non facilmente raggiungibili in una ordinaria manutenzione (come per es. quelle della 1° balaustra) se non dall’interno dei palchi.
- Nappine (motivo decorativo ricorrente) bordatura palchi, dorate a missione: ca. 40 pezzi mancanti e numerosi da ricostruire parzialmente.